
Sponsor

|
CULTURA ITALIANA NEL MONDO - 500 PALAZZO TE: E' RINASCIMENTO A MANTOVA "DAL CAOS AL COSMO" CON "LE METAMORFOSI DI OVIDIO"
(2025-03-14)
"DAL CAOS AL COSMO. METAMORFOSI A PALAZZO TE" a MANTOVA per i 500 anni di Palazzo Te' - dal 29 marzo al 29 giugno 2025 - a cura di Claudia Cieri Via.
IL PERCORSO DELLA MOSTRA
Il racconto delle Metamorfosi di Ovidio attraversa le camere, le sale e le logge di Palazzo Te, dal caos delle origini alla dimensione temporale della storia, dalla übris dei mortali e le conseguenti punizioni da parte degli dèi, all’affermazione della loro supremazia sugli esseri umani. Il percorso all’interno di Palazzo Te enuncia in apertura, attraverso i miti di Orfeo ed Euridice, di Apollo e Marsia e di Apollo e Pan, la Contrap-posizione fra le divinità, gli esseri umani e semiuman i nella polarità fra apollineo e dionisiaco, che si esprime in particolare nella musica a corda di Apollo e di Orfeo e nella musica a fiato di Pan, nella danza armoniosa delle Muse e delle Grazie e in quella sfrenata delle Menadi e dei Satiri.
Le metamorfosi, dunque, coinvolgono la vita degli esseri umani, ma anche degli animali e delle piante, fino ad arrivare a processi di ibridazioni, di deformazioni, di cambiamenti di status che trovano una grandiosa es pressione “nell’affresco cosmogonico” di Ovidio e di Apuleio che Giulio Romano mette in scena nelle pitture, negli stucchi, nelle decorazioni e nei linguaggi architettonici di Palazzo Te attraverso le sue metamorfosi in un mondo in continua trasformazione.
Da queste forme in incessante movimento prendono le mosse anche gli scrittori e gli artisti contempora- nei, che frequentemente attingono alle Metamorfosi di Ovidio per immergersi nel mondo della natura vegetale e animale in un sentire all’unisono, per esprimere, al massimo delle loro potenzialità, le speri - mentazioni di dinamismi in mutamento. È il caso di Dafne, che nella sua metamorfosi nella pianta dell’al-loro sublima la violenza di Apollo, oppure di Siringa, che inseguita dal satiro si trasforma nelle canne che andranno a costruire la siringa di Pan, simbolo di armonia, ma anche di Arianna, che viene sublimata in una costellazione, o di Fetonte che sbalzato dal carro di Apollo per aver osato avvicinarsi troppo al sole precipita nel fiume Po, come racconta Ovidio.
Il lavoro di Penone sulla materia vivente è esemplare di questa filosofia della natura per trovare una certa assonanza con il processo artistico di Giulio Romano sulla trasformazione/deformazione delle forme archi-tettoniche assimilabili alla natura: dalle colonne tortili ai triglifi slittati che nell’ibridazione con le forme della natura, ma anche con il mostruoso e il grottesco, esprimono una rottura dei canoni stilistici classici nelle architetture in continuo movimento, in quelle trasformazioni manieriste che trasmettono anche una certa instabilità e trovano espressione nel potente affresco della caduta dei Giganti.
I. LE FAVOLE DI OVIDIO
Le favole latine e i miti greci rappresentano da una parte l’evasione della realtà nel fantastico, dall’altra
le interpretazioni della realtà in forma simbolica. In questo senso è esemplare la decorazione complessiva di Palazzo Te, dimora di ozi e di piaceri, dove Federico II Gonzaga scelse le Metamorfosi di Ovidio come racconti allegorici del suo carattere e delle sue virtù. È ciò che ci riferiscono le testimonianze in merito all’operato di Giulio Romano e della sua scuola, che a partire dalla Camera di Ovidio ricordano l’antico non solo nei soggetti ma anche nella composizione, che richiamano quelle del terzo stile pompeiano, su sfondo scuro e alternate a piccole scene di paesaggi. Qui le narrazioni ovidiane, attraverso i magnifici disegni di Giulio Romano, mettono in scena miti di amore e morte, come quelli di Orfeo ed Euridice, o della gara musicale fra la musica apollinea e dionisiaca fra Apollo e Pan e fra Apollo e Marsia.
II. LA CICLICITÀ DEL TEMPO
Il percorso attraverso le Metamorfosi raffigurate a Palazzo Te trova un importante nucleo nella Camera del Sole e della Luna, dove Giulio Romano raffigura sulla volta il carro di Apollo e quello della Luna in movimento l’uno dietro l’altro, restituendo una efficace immagine del grande tema della ciclicità del tempo che apre il secondo libro del poema di Ovidio.
III. VIRTÙ, EROS E POTERE
All’interno di questa sezione, che si apre con il confronto tra i monocromi della sala dedicati alle vicende di Ercole e le incisioni tratte da questo apparato decorativo, viene evocato il celebre ciclo degli Amori di Giove, commissionato da Federico II Gonzaga a Correggio in occasione del soggiorno di Carlo V a Mantova. Le opere con le trasformazioni del padre degli dèi, qui esposte in originale o in copie del XVII secolo, sono tra le raffigurazioni più sensuali e coinvolgenti di tali miti.
Ma come racconta Ovidio nelle Metamorfosi (VI, vv., 1-145) le feroci passioni del padre degli dèi vengono denunciate nel divenire il soggetto dell’opera di tessitura con cui la giovane Aracne sfida Minerva in una gara al telaio. La dea incolpando la giovane tessitrice di un grave atto di superbia, la punisce trasformandola in un ragno. La vicenda è ben raffigurata da Jacopo Tintoretto nel dipinto che si conserva alla Galleria degli Uffizi.
IV. EROS, IBRIDAZIONI E SUBLIMAZIONE
Il dialogo non avviene solo tra le varie favole antiche, ma anche tra autori. È in questa sala che si materializza il rapporto tra la narrazione ovidiana e quella di Apuleio. Il racconto del mito di Amore e Psiche è qui rappresentato nella volta con toni scuri e scorci incredibili che comunicano attraverso le improvvise illuminazioni i momenti della storia legati alle trasgressioni e alle punizioni. L’incontro tra i due amanti viene ben descritto, e in questa occasione posto a confronto, anche dal pittore Jacopo Zucchi, che con la stessa cura dei particolari rappresenta ogni oggetto presente nella stanza in cui si incontrano il dio e la bellissima giovane.
Nella parte bassa si avvia un racconto per lo più gioioso che si svolge sulle pareti sottostanti dove la solarità del banchetto nuziale è seguito da altri miti d’amore e morte, come Venere e Marte e Venere e Adone, ma anche da metamorfosi, in continuità con quanto già proposto a Roma da Raffaello, Sebastiano del Piombo e dallo stesso Giulio Romano in vari contesti decorativi, tra i quali quello di Polifemo e Galatea sia nella Loggia della villa di Agostini Chigi a Roma, sia nella loggia di Villa Madama.
V. L’ORDINE DELLE STELLE
La metamorfosi è movimento continuo, dal cosmo, qui rappresentato nella complessità dei venti e delle costellazioni che influenzano i caratteri degli esseri umani, al caos, che attiva tematiche come il doppio, l’ibrido e la trasformazione di corpi e forme.
Il mito di Narciso è doppio nel suo rispecchiamento sull’acqua ed è doppio nell’eco del suono e della voce della ninfa Eco, ma entrambi tendono all’unità, al cosmo, come Ermafrodite e Salmace.
VI. SUPERBIA, PUNIZIONE, VIOLENZA
La rappresentazione della caduta di Fetonte, che perso il controllo dei cavalli del carro di Apollo rovina, campeggia sulla volta della Camera delle Aquile in un meraviglioso e ardito scorcio prospettico.
In questo ambiente, negli stucchi della volta la metamorfosi assume il significato di strumento d’inganno per le divinità dell’Olimpo ai fini di insidiare e rapire le giovani ninfe per possederle. È il caso del ratto di Europa da parte di Giove, di Anfitrite da parte di Nettuno ma anche di Proserpina rapita da Plutone. I magnifici disegni di Giulio Romano per questi stucchi sono per lo più ispirati a rilievi antichi, come nel caso del sarcofago con il ratto di Proserpina, ripreso, anche attraverso la mediazione del disegno di Giulio Romano, da Rubens nel dipinto che si conserva a Parigi (Musée du Petit Palais) e che l’artista poteva aver visto in occasione del suo soggiorno a Mantova nel primo decennio del Seicento.
VII. METAMORFOSI E PERFORMANCES NELL’ARTE E NELLA NATURA
Il racconto del poema di Ovidio approda dal caos delle origini del mondo alla dimensione temporale.
Da queste forme in continua trasformazione prendono le mosse anche gli scrittori, i poeti e gli artisti contemporanei che attingono ai miti delle Metamorfosi di Ovidio per immergersi nella natura vegetale e animale in un sentire all’unisono. Fra questi è emblematica la vicenda di Dafne, che nella sua trasformazione in alloro sublima nella pianta il terrore della violenza di Apollo.
Il lavoro di Penone sulla materia vivente è esemplare di questa filosofia della natura, così come quello di Giulio Romano che elabora il movimento negli elementi architettonici e nelle decorazioni plastiche, che da oggetti si trasformano in profili umani, animali o naturali.
VIII. DAL CAOS AL COSMO: L’ANTICO, LA STORIA, I TRIONFI
Le Metamorfosi di Ovidio sono un testo fondamentale anche dal punto di vista storico, dato che il poeta decide di concludere la sua opera con l’apoteosi di Cesare, narrata nel libro XV. Infatti, il poema venne ultimato nel primo decennio del I secolo d.C. e al suo interno vengono narrati oltre duecentocinquanta miti del mondo antico. La sua straordinaria importanza consiste nella radicale novità con cui il poeta augusteo – celebrato da Nicolas Poussin nel dipinto che raffigura il suo Trionfo probabilmente assumendo la fisionomia del più grande poeta e letterato del tempo, Giovan Battista Marino – affrontò l’argomento mitologico, che, dietro una apparenza di favola, nasconde un alto significato morale. Il suo ritratto si può infine rispecchiare negli stessi versi del poeta che concludono le Metamorfosi.
«E ormai ho compiuto un’opera che né l’ira di Giove né il fuoco, né il ferro, né il tempo che tutto rode potranno cancellare. Quando vorrà verrà pure il giorno fatale e…ponga fine allo spazio della mia vita. Ma con la parte migliore di me io volerò in eterno più in alto delle stelle, e il nome mio rimarrà indelebile. E ovunque si estenda sulle terre domate la potenza romana, le labbra del popolo mi leggeranno e per tutti i secol, grazie alla fama, se qualcosa di vero c’è nelle predizioni dei poeti, io vivrò.» (Metamorfosi, XV, vv. 870-874) (14/03/2025 -ITL/ITNET).
|
Altri prodotti editoriali
Contatti
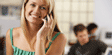


|